Nel suo ricordo di Gianni Toti sui «Cahiers du Cinéma»
(marzo 2007) Jean-Paul Fargier esordisce con la rievocazione
di una sequenza di SQUEEZANGEZAÙM (1988): la prua
virtuale della corazzata Potemkin che squarcia lo schermo
bianco, come a dirigersi verso gli spettatori. Alla RAI di
Torino, aiutato dai suoi “montautori” e dai suoi “chimeramen”,
Toti aveva sperimentato le strumentazioni per gli
effetti elettronici e realizzato in video l’idea di Ejzenstein,
che avrebbe voluto, alla fine del suo film, una lacerazione
reale dello schermo da parte dell’immagine della prua che
avanza. LA CUIRASSÉ POÈTEMKINE, così Toti aveva rinominato
il film in quel suo videopoema che è un omaggio alle
utopie artistiche e politiche del Novecento, al linguaggio
transmentale di Chlébnikov, alla poesia di Majakovskij.
Frammenti di film si susseguono, intrecciandosi alle
musiche: Toti li rielaborava proprio come faceva con le
parole, per creare significati (“sognificati”, diceva) nuovi,
nuove associazioni di memoria e di immaginazione.
«Faceva cose nuove con le vecchie – scrive ancora Fargier.
Con associazioni forsennate, innesti, sovrapposizioni
di strati, intreccio di frammenti». Del resto, «nei suoi
testi brulicano parole-valigia lanciate in italiano, in francese,
in spagnolo, in russo, in inglese, con la sua voce di
poliglotta post-joyciano ispirato dal trans-linguismo,
arrotolando le sillabe come un declamatore sulle scene,
staccandole l’una dall’altra per far meglio gustare l’origine
di ognuna, spesso prelevandole da lingue diverse. Il suo modello era lo “zaùm” di Chlébnikov: la marmitta futurista, il melting-pot di tutti i linguaggi fusi per creare un parlare inaudito, il solo degno di esprimere la novità
dei tempi rivoluzionari». Quella del cinema è una
traccia che percorre tutta la riflessione e la creazione artistica
di Toti. A partire dalla battaglia per il grande cinema
di poesia, nel dibattito culturale del dopoguerra. «Io
e alcuni altri – una minoranza, effettivamente – eravamo
contrari a tutta l’esaltazione, la retorica neorealista nel
cinema e negli altri campi... Noi, proprio con un rifiuto e
un’uscita di campo, facevamo altre cose... Il cinema celebrato
in tutto il mondo per noi era retrivo nei confronti
del grande cinema di poesia... per quel cinema verista,
naturalista, gli Ejzenstein non esistevano...», mi aveva
detto in una conversazione (Roma, 1995).
Amico di Zavattini – con cui aveva collaborato per i CINEGIORNALI
LIBERI, non cessava di polemizzare con un cinema
inteso come “macchina da prosa” (così diceva), incapace di
articolare, elaborare, trasformare poeticamente la realtà in
linguaggio “altro” o, peggio ancora, piegato a esigenze di
propaganda politica, tentato dall’infausto richiamo del
“messaggio”. È illuminante rileggere oggi i suoi contributi
per la rivista «Cinema & Film», come quello su Ejzenstein
e Vertov (1967) in cui si dialoga con le problematiche
della cine-verità e del cine-occhio. Vi si intravedono, tra le
righe, affermazioni simili a quelle che Toti farà poi, negli
anni Ottanta e Novanta, sul presunto super-occhio elettronico.
«Non basta essere “maestri della vista” – scriveva nel
1967 –, bisogna creare le cose da vedere e che non ci sono
nella verità visuale dell’occhio umano e dell’occhio cinematografico
se non interviene l’autore mitopoietico a farti
conoscere ciò che lui ha costruito per dirti la vita guardata
con gli strumenti più perfezionati, agili e intelligentemente
e persino artisticamente manovrati». A Dziga Vertov
aveva dedicato, nel 1994, PLANETOPOLIS: a lui, la “trottola
volteggiante”, citato in immagini con frammenti de L’UOMO
CON LA MACCHINA DA PRESA; il progetto stesso di questa
gigantesca “video-poem-opera” aveva preso le mosse da
un Simposio sul cineasta, a Mosca, nel 1992. E SQUEEZANGEZAÙM
è un’opera video intessuta di omaggi al cinema:
quello classico (John Ford), quello d’animazione, quello
delle avanguardie storiche. Atto d’amore nei confronti di
un secolo di rappresentazioni e utopie schemiche, quelle
che ci hanno reso tutti “spettratori”, spettatori di ombre, di
spettri, di sogni. Un cinema che si trasforma, proprio nel
senso dello “zaùm”, del linguaggio transmentale di Velimir
Chlébnikov. Torna indietro, si ripete, gioca con se stesso,
si avvita su altre immagini, percorre altre forme, ricrea
didascalie e titoli, come accadrà poi in tutta la produzione
“poetronica” di Toti. Ricordo, durante la post-produzione
di PLANETOPOLIS, il trattamento di immagini di OTTOBRE di
Ejzenstein, con la folla mandata all’indietro, le bandiere
colorate in rosso sul bianco e nero; le sequenze di Pelescian,
di Medvedkin, di Vertov, di Ruttmann ma anche di
documentari scientifici; di Lang, Pennebaker, Marker...
Del resto, forse la sua opera video più toccante, quella che
ha conquistato alle arti elettroniche vari autori e vari critici
(come si è detto recentemente al festival di Clermont-
Ferrand, durante un omaggio a Toti) è INCATENATA ALLA
PELLICOLA del 1982 (una delle parti della TRILOGIA MAJAKOVSKIANA
per la Sperimentazione RAI). Quel frammento di pellicola, di due minuti, salvato dalla distruzione e donato a Toti dall’amica Lilj Brik, compagna per tanti anni
di Majakovskij, veniva dal film di Nikandr Turkin del
1919: vi recitavano i due,mettendo in scena la storia di una
ballerina che esce dallo schermo per amore del giovane
“reale”. Grazie all’intuizione delle possibilità di metamorfosi
e dilatazione temporale e delle alterazioni spaziali e
cromatiche del video, grazie alle parole recitate, alle citazioni
poetiche, all’ingrandimento di dettagli e gesti, a ripetizioni,
incantamenti, malinconie storiche (“malincosmie”,
come diceva Toti), il frammento (ri)diventa opera compiuta,
interpreta nell’arco di un’ora le speranze e le delusioni
di un’intera generazione di appassionati rivoluzionari della
parola e dell’arte, porta alla luce e a nuova vita una
scheggia di memoria altrimenti destinata alla scomparsa.
In modo poetico, evocativo, talora enigmatico, queste
opere sono anche un percorso di riflessione politica,
offrono materia di dubbio e pensiero sull’ascesa e il declino
(o il provvisorio silenzio) del comunismo, che Toti
aveva rinominato “coSmunismo” per sottolinearne la
vocazione planetaria, a venire, al di là di questa o quella
frettolosa e malintesa applicazione.
Il cinema Gianni Toti non lo aveva solo amato, commentato,
studiato, utilizzato nei video. A un certo punto lo
aveva anche fatto, sia come attore (per Faccini, gli
Straub, Gutierrez Alea e altri), sia come soggettista e sceneggiatore
di molti testi che sono rimasti allo stadio di
progetto, sia con due film realizzati: E DI SHAÙL E DEI
SICARI SULLE VIE DA DAMASCO (1973) e ALICE NEL PAESE DELLE
CARTAVIGLIE (1980, operazione cui sono correlati anche
un libro e un 45 giri musicale).
È interessante rileggere oggi i dibattiti (soprattutto su
SHAÙL, montato da Roberto Perpignani e interpretato da
GeorgeWilson) su riviste di quel periodo, da «Cineforum»
alla «Rivista del Cinematografo» a «Cinema Nuovo» e a
«Cinemasessanta». Si tratta di un film che capovolge l’idea
di “cinema storico” e che si costruisce con salti temporali,
provocazioni (i titoli di testa a metà del film), effetti, come
a chiamare il video, più versatile e malleabile della pellicola,
più disposto per la sua natura vibratile e puntiforme
alle “piegature” del linguaggio. «Penso ai film (dice Toti in
uno di questi articoli) come a “libri di immagini sonore e
visive”, che possono quindi aver bisogno di prefazioni, di
post-fazioni, di interventi sulla tessitura, indicazioni utili
al lettore-spettatore perché si fabbrichi da solo le sue “chiavi
di lettura” o di “slettura”, o di “illettura”...».
Scrittore di tutte le scritture, Toti ci fa capire qui come nel
suo itinerario creativo non si tratti di “passare” da un mezzo
a un altro, da una scrittura a un’altra (magari più evoluta
tecnicamente). La pagina – letteralmente e metaforicamente
– è una sola, foglio bianco e chiarore dello schermo,
superficie di proiezione cinematografica e quadro del
monitor. Negli anni Ottanta Gianni Toti diventa unmaestro
della sperimentazione in elettronica, internazionalmente
conosciuto, premiato, celebrato (più all’estero che in Italia,
va detto) fra i pionieri più radicali e più colti del panorama
video. Torna nella “poetronica” la sovversione dei linguaggi,
torna il cinema (medium ormai “completamente nato”
secondo Toti) come modulo del discorso in video, ma
nascono anche figure mai viste prima, avventure di forme,
impaginazioni e creazioni – anche in digitale – di
straordinario impatto sensoriale, intellettuale ed emotivo.
Se leggiamo le analisi critiche del suo lavoro letterario e poetico (come quelle, acutissime, di Giuseppe Zagarrio) riconosciamo le “figure retoriche” totiane, le sue invenzioni, i suoi capovolgimenti di linguaggio, le sue decostruzioni,
anche nelle immagini video: così come il suo respiro
planetario e cosmico, la sua “ironia antroposociologica”, il
suo sguardo sul futuro possibile e “poesibile”. Come ha
ben dimostrato una giovanissima studiosa, Silvia Moretti
(quanti giovani intorno all’opera di Gianni Toti, quanta
attenzione e passione riscuote il suo lavoro negli studenti
che vi si accostano o che l’hanno conosciuto di persona), si
tratta di uno schermo-video-pagina da percorrere con la
scrittura, sfogliare, attraversare, «in una continuità di reciproco
nutrimento tra l’arte scrittoria e visiva». Del resto, i
suoi video-poemi sono affollati di lettere e parole danzanti
e vive, animate (futuristicamente), divenute immagini o
contenitori di immagini; il cinema stesso, prelevato per
“frasi”, diventa un elemento del discorso: commuove un
piccolo Gramsci infagottato, filmato a Mosca (in GRAMSCIATEGUI),
commuove la ballerina Lilj che ha nostalgia della
tela bianca dello schermo, i soldati a cavallo che tornano
indietro, le masse avanzanti che non avanzano più... Pagina,
cinema, video? Parola, scrittura, musica?
Forse la lezione più alta di Gianni Toti, inscindibile dal
rigore e dalla freschezza che assumeva in lui l’esame puntuale
delle varie arti che ha attraversato (e di cui è stato
anche un teorico, formulando concetti e coniando terminologie),
sta proprio in questa poetica e in questa pratica
artistica della compresenza e dell’assunzione “totale” dei
linguaggi. Che fa del resto tutt’uno con la feconda, appassionata
convivenza – nella sua arte e nella sua esperienza
di vita – di tante lingue vive e “morte”, di tanti capolavori
letterari di tutti i tempi, di tante e diverse suggestioni
musicali, conoscenze teatrali, filmiche, scientifiche, filosofiche.
Ma anche di tanti paesi attraversati, persone note e
ignote, incontrate e mai dimenticate, avventure straordinarie,
straordinarie battaglie: umane, poetiche, politiche,
intellettuali. Il partigiano Vania, il militante del “proletariato”,
volentieri cantava quei versi del musicista e poeta
argentino Atuahalpa Yupanqui, cantore degli Indios e dei
dannati della terra, che aveva inserito anche in PLANETOPOLIS:
“prima esser uomo, poi poeta”.
Anche in questa direzione andrà riletta e ripensata e
“riscritta” la sua opera. E ri-vissuta. In modi diversi e nuovi
ma sempre producendo e ragionando e scrivendo e filmando
e inventando e creando senza mai arrendersi al
facile, all’ovvio, al noto. E ancora scrivendo e creando e
ragionando e filmando e producendo e…
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

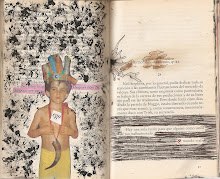
No hay comentarios:
Publicar un comentario